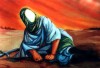Ho ricordi personali vivissimi degli
anni Sessanta. Questo di per sé, ovviamente, non è una garanzia di oggettività e
di attendibilità, perché è evidente che il coinvolgimento soggettivo non può
essere in nessun modo una prova scientifica di profondità nell’interpretazione
(come ben sanno gli esperti di storia orale, coscienti del fatto che i testimoni
diretti possono a volte deformare la realtà dei fatti assai più di quanto
possano fare degli estranei totali).
Io sono nato nel 1943, e gli anni Sessanta
coincidono con i miei studi universitari, compiuti in larga parte all’estero (in
Francia e in Grecia), con la scoperta della mia vocazione filosofica e con la
mia vocazione politica comunista e marxista, ed infine con i due eventi del
matrimonio e della scelta della professione (i due eventi considerati dal
filosofo tedesco Hegel come i due eventi cruciali nel passaggio dall’astrazione
intellettuale dell’età giovanile alla concretezza razionale e determinata
dell’età adulta). Il lettore mi perdonerà questa piccola parentesi
autobiografica, ma essa viene qui introdotta solo per collocare il contesto del
mio giudizio sugli anni Sessanta in Italia, da cui inizia logicamente la mia
riflessione sulla scuola.
Per una parte importante della gioventù italiana
ed europea gli anni Sessanta sono stati il grande decennio della modernizzazione
capitalistica soggettivamente vissuto come il decennio dell’anticamera
rivoluzionaria del passaggio al comunismo. Oggi è estremamente difficile
spiegare questo ad un giovane, dato il radicale cambiamento della situazione
storica che si è avuto nel frattempo. Tuttavia, la comprensione del paradosso
dialettico della compresenza conflittuale fra modernizzazione capitalistica ed
utopia rivoluzionaria è difficile anche per i membri della generazione del
Sessantotto, che tendono a rimuovere nevroticamente questo paradosso, e si
dividono facilmente nelle due grandi categorie dei nostalgici e dei rinnegati.
Il nostalgico continua a pensare che l’utopia rivoluzionaria non è stata
realizzata soltanto per errori politici di tipo soggettivo, e che dunque lo
“spirito del Sessantotto” deve essere mantenuto ed eternizzato, sia pure con le
modificazioni di tattica politica che questo richiede. Il rinnegato, invece,
considera il perseguimento dell’utopia rivoluzionaria uno sciagurato anche se
inevitabile equivoco giovanile, cui la saggezza dell’età sostituisce l’adesione
attiva ai valori dell’impero americano (il caso di Adriano Sofri è in proposito
assolutamente esemplare).
Le testimonianze dei
nostalgici e dei rinnegati sono ovviamente opposte, ma hanno un segreto elemento
in comune. E questo elemento sta proprio nella mancata comprensione del
meccanismo teorico che permise la sovrapposizione dell’utopia rivoluzionaria
comunista alla sostanza della modernizzazione capitalistica del costume e dei
riti sociali e generazionali. Una volta che questo elemento sia stato compreso,
il paradosso cessa di essere paradossale, e diventa assolutamente
concettualizzabile, e quindi comprensibile, e quindi anche accettabile
serenamente senza nostalgia ma anche senza vergogna e ripudio. Si tratta del
fatto che la generazione del Sessantotto, che si accostò e praticò per almeno un
decennio l’utopia rivoluzionaria comunista, quasi sempre in piccoli gruppi
impropriamente definiti “estremisti” (impropriamente, perché invece
interpretavano bene non “l’estremo”, ma il “normale” ed il “tipico” dello
spirito del tempo), identificò il capitalismo con la borghesia, o più
esattamente l’economia capitalistica con il costume familiare e sociale
borghese, e pensò che rivoltandosi contro la borghesia e la sua cultura si
rivoltava anche e soprattutto contro lo sfruttamento capitalistico. In Italia
questo avvenne attraverso l’adozione di massa della variante operaistica del
marxismo, in cui la classe operaia era divinizzata, ma anche segretamente
disprezzata con il suo essere ridotta a strumento degli astratti furori
iconoclastici della rivolta generazionale della piccola borghesia contro
l’autoritarismo paterno.
La classe operaia, per conto suo, in modo parallelo ma
assolutamente indipendente, perseguì invece non il progetto operaistico, cioè la
comunistizzazione fantasmatica della propria collocazione sociale, ma
l’integrazione migliorata nella società capitalistica mai messa seriamente in
discussione, e trovò nel sindacato unitario CGIL-CISL-UIL e nel partito PCI (poi
PDS ed infine DS) il suo sbocco sociale e politico logico, razionale e coerente.
Questa concezione antropomorfica del capitalismo, anzi del modo di
produzione capitalistico, che è un sistema impersonale e non un soggetto
personale trascendentale, avrebbe già potuto essere respinta con gli argomenti
di Spinoza e poi di Hegel, filosofi che seppero molto bene al loro tempo
respingere le ingenue antropomorfizzazioni della società. Ma questo non avvenne,
perché la filosofia è una grande maestra che insegna sempre in un’aula vuota.
In
breve: la scorretta antropomorfizzazione concettuale di un ente per sua natura
non antropomorfico, il modo di produzione capitalistico, era lo strumento
ideologico più adatto, ed anzi ideale, per poter condurre una rivolta
generazionale anti-borghese volta alla modernizzazione ipercapitalistica del
costume all’interno della falsa coscienza necessaria (uso qui un concetto di
Marx di cui non cesso di ammirare la pregnanza e la pertinenza esplicativa) di
stare conducendo una lotta anticapitalistica. Questa lotta in realtà non poteva
essere condotta su queste basi anti-borghesi, per il semplice fatto che era il
capitalismo stesso nel suo anonimo ed impersonale meccanismo autoriproduttivo a
premere per una deborghesizzazione controllata del costume in una direzione
post-borghese, in vista di una individualizzazione ulteriore manipolatoria della
figura del consumatore, resa finalmente astratta e flessibile, e non più
vincolata a costumi borghesi parzialmente contraddittori con quella
liberalizzazione nichilistica e totalitaria. Il capitalismo sottomette infatti
alla propria riproduzione non solo il proletariato, come è largamente noto, ma
anche la borghesia, e non solo la piccola borghesia, come è altrettanto noto, ma
la stessa grande borghesia, come è meno noto, ma come già a suo tempo filosofi
come Adorno e scrittori come Thomas Mann capirono già molto bene.
alla parte successiva
Gli articoli apparsi originariamente su questo sito possono essere riprodotti liberamente,
sia in formato elettronico che su carta, a condizione che
non si cambi nulla, che si specifichi la fonte - il sito web Kelebek http://www.kelebekler.com -
e che si pubblichi anche questa precisazione
Per gli articoli ripresi da altre fonti, si consultino i rispettivi siti o autori
|
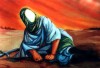
e-mail
Home | Il curatore del sito | Oriente, occidente, scontro di civiltà | Le "sette" e i think tank della destra in Italia |
La cacciata dei Rom o "zingari" dal Kosovo | Il Prodotto Oriana Fallaci | Antologia sui neoconservatori | Testi di Costanzo Preve | Motore di ricerca | Kelebek il blog