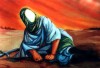A questo punto ritengo necessario introdurre un breve inciso. Si usa in modo un po’ sconsiderato
parlare di questo tipo di cultura populistico-pedagogica in termini di Marx e di
marxismo, o meglio di sciagurata egemonia del marxismo. Personalmente, ho
dedicato a Marx ed al marxismo almeno due decenni di studi, e mi considero un
conoscitore serio sia della teoria di Marx che della variegata e complessa
storia del marxismo.
Ebbene, questo populismo pedagogico, per metà laico ed
anticlericale e per metà cattocomunista, non c’entrano assolutamente nulla con
Marx, erede diretto dell’illuminismo e del romanticismo, e dunque del grande
liceo tedesco dell’Ottocento. La matrice deve essere piuttosto fatta risalire
alla corrente detta dell’operaismo italiano, ed in particolare ai suoi due
elementi costitutivi fondamentali, e cioè il sociologismo e l’economicismo.
Ciò
che i non specialisti (e cioè il 98% dei commentatori giornalistici della
storia) credono sia il pensiero di Marx è in realtà un impasto altamente
sgradevole ma anche altamente volatile (e cioè a bassa conservazione) di
sociologismo e di economicismo. Questo è particolarmente chiaro nella questione
scolastica. Per sociologismo intendo l’idea del riassorbimento della cosiddetta
separatezza della scuola nel corpo diretto della società, intesa per di più come
l’estensione spaziale di una grande fabbrica. Per economicismo intendo
l’ossessiva riduzione dell’istituzione scolastica a fornitrice del mercato del
lavoro capitalistico e di controllo del cosiddetto esercito industriale di
riserva. Questo impasto di sociologismo e di economicismo, cui si associa
irresponsabilmente il nome onorato di Marx, è particolarmente evidente nel
cruciale documento cui farò ora riferimento.
La rivista mensile Il Manifesto (non ancora quotidiano) pubblica nel suo
numero 2, febbraio 1970, delle Tesi sulla Scuola firmate a sei mani da
Rossana Rossanda, Marcello Cini e Luigi Berlinguer, che sono uno sconcertante
concentrato profetico del futuro quinquennio Berlinguer-De Mauro del 1996-2001.
Vale la pena farvi alcune considerazioni “dialettiche”, che spieghino cioè come
le stesse impostazioni, mutato il tempo storico in cui vennero espresse, possono
rovesciarsi nel loro esatto contrario.
Le Tesi sulla Scuola del 1970
sono un manifesto dell’utopia della descolarizzazione, cioè dell’integrale
fusione del momento educativo e formativo con il momento sociale e politico.
Come tutte le utopie della fusione, si tratta di un fraintendimento radicale e
fatale del fondamento filosofico ed antropologico del comunismo moderno di Marx,
che è un comunismo delle libere individualità autonome e non della fusione
populistica o sociale. Ma qui, se è possibile, vi è un fraintendimento ancora
più grave. Qui non si capisce neppure la ragione per cui i fondatori della
scuola moderna, dal 1780 al 1830, ebbero ben chiaro il concetto per cui la
scuola non doveva “rappresentare” o “rispecchiare” la società così com’era (non
importa se in variante statica o movimentistica, di destra o di sinistra,
eccetera), ma doveva costituire un momento relativamente separato.
Questa
separatezza, lungi dal rappresentare un ritardo conservatore da colmare,
rappresentava una garanzia inestimabile di autonomia dalle pressioni dirette ed
immediate dell’economia e della politica. Per usare il linguaggio delle scienze
sociali moderne, i governi cambiano, le mode culturali cambiano ogni decennio,
le cosiddette esigenze del mercato del lavoro mutano con i conseguenti profili
professionali richiesti, le pressioni giornalistiche mutano, eccetera, mentre la
scuola come istituzione non può e non deve correre dietro a tutti questi
inevitabili mutamenti sociali, ma deve dotarsi di una sua temporalità autonoma
in cui strutturare il momento educativo.
Confluivano in questa razionale
concezione di separatezza (ovviamente relativa) il razionalismo illuministico e
l’idealismo romantico. La scuola è infatti il luogo della paideia,
dell’educazione dei sentimenti e della ragione, ed il distacco prospettico dalla
società così com’è è la precondizione ottica per non farsi assorbire e succhiare
dentro una contemporaneità che poi è anch’essa fasulla, perché è un tempo che
scorre e scompare istantaneamente. Tutto questo, ovviamente, non impedisce un
riformismo scolastico anche radicale nei cambiamenti delle materie, dei metodi
di insegnamento e negli assi culturali. Impedisce soltanto una impossibile
antropologia della fusione dell’individuo con la società, fusione che viene
invocata sempre in nome della comunità (di volta in volta religiosa,
nazionalistica o proletaria, eccetera), laddove rende proprio impossibile ogni
costituzione vera di comunità, perché una comunità reale è composta da
individualità libere ed autonome.
Abbiamo così individuato il difetto che a mio avviso sta nel manico, ed il manico era tenuto
saldamente in mano da quell’ispirazione culturale sessantottina che era del
tutto egemone presso quella categoria di intellettuali-massa prevalente
nell’insegnamento elementare, medio e secondario. Le dinamiche della
costituzione dell’intellettualità universitaria sono diverse, in quanto hanno a
che fare con la costituzione della parte inferiore dei ceti dominanti, e non con
la parte superiore dei ceti dominati. Questo dà luogo ad una tipica situazione
di scissione simbolica fra Noi e Loro che non deve essere ridotta a semplici
questioni di stipendio (in questo contesto del tutto secondarie, anche se pur
sempre significative, perché non si vive di aria e nei negozi bisogna pagare),
perché hanno a che fare non solo con il cosiddetto prestigio dello status
sociale, ma con l’accesso ai media e con il diritto ad essere ascoltati. E’
chiaro a tutti, ad esempio, che il diritto di un magistrato ad essere ascoltato
dall’opinione pubblica è mille volte superiore al diritto di un insegnante a
veder compreso il proprio punto di vista. La macchina spocchiosa del
giornalismo, ad esempio, equipara il lamento dell’insegnante alla mormorazione
plebea dell’operaio, identificato con un inesistente Cipputi. Tutto questo,
purtroppo, non è innocente, perché rinsalda nell’insegnante quelle
caratteristiche negative del risentimento, del rancore, dell’invidia che sono
tipiche di ogni plebeismo regressivo ed impotente.
alla parte successiva
Gli articoli apparsi originariamente su questo sito possono essere riprodotti liberamente,
sia in formato elettronico che su carta, a condizione che
non si cambi nulla, che si specifichi la fonte - il sito web Kelebek http://www.kelebekler.com -
e che si pubblichi anche questa precisazione
Per gli articoli ripresi da altre fonti, si consultino i rispettivi siti o autori
|
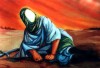
e-mail
Visitate anche il blog di Kelebek
Home | Il curatore del sito | Oriente, occidente, scontro di civiltà | Le "sette" e i think tank della destra in Italia |
La cacciata dei Rom o "zingari" dal Kosovo | Il Prodotto Oriana Fallaci | Antologia sui neoconservatori | Testi di Costanzo Preve | Motore di ricerca