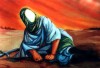In
primo luogo, con la stragrande maggioranza dei cosiddetti intellettuali
comunisti e marxisti, ho dato per scontato per almeno un ventennio che la
sinistra fosse lunico luogo storico e culturale possibile non solo per la
rivoluzione, ma anche per la razionalità e il progresso dellumanità. Si
trattava di un presupposto di autosufficienza che conteneva un aspetto
parzialmente narcisistico, evidente oggi nella crociata antiberlusconiana di
personaggi che approvano tutte le guerre imperiali americane, ma poi credono
che il problema dei problemi sia il cattivo gusto delle televisioni private o
il conflitto di interessi. Questo presupposto di autosufficienza mi spingeva
ovviamente a condividere il "tabù dellimpurità" verso chiunque si dichiarasse
di destra o di estrema destra. Non mi era chiaro, e non poteva esserlo ai miei
coetanei ingannati, che il prolungamento di questa guerra civile simulata
serviva soltanto a riprodurre un sistema politico consociativo (ancorché
migliore di quello nato dopo il 1992 ad opera del colpo di stato giudiziario
di Mani Pulite). In poche parole, per dirla in termini cartesiani, non ero
stato ancora investito né dal dubbio metodico né tantomeno dal dubbio
iperbolico.
In secondo luogo, ripeto quanto già scritto in molte altre sedi, e
cioè che considero gli esiti storici del Sessantotto un episodio della storia
dellindividualismo radicale contemporaneo (chi ha sostenuto con migliori
argomenti questa tesi è stato il francese Lipovetsky). Il Sessantotto, almeno
in Italia e Francia, si caratterizza per la compresenza di una spinta
irresistibile alla modernizzazione post-borghese dei costumi, da un lato, e di
una falsa coscienza ideologica che mascherava questa modernizzazione
post-borghese con lassunzione di una utopia comunista e libertaria, vissuta
peraltro in buona fede in quasi tutti i casi. In quanto tale, il Sessantotto
non è dunque la matrice dei partitini rivoluzionari del periodo 1969-1977 e
neppure della lotta armata brigatista in Italia. Lideologia di destra che fa
questa equazione è del tutto fuori strada.
In terzo luogo, se si studia
lideologia italiana dei micropartitini erroneamente detti estremistici degli
anni 1969-1977 (Lotta Continua, Potere Operaio, Avanguardia Operaia, partitini
marxisti-leninisti, eccetera), si deve sapere che il loro riferimento a Marx
ed a Lenin era del tutto formale, astratto ed infondato. Il marxismo era
assunto nella forma delloperaismo italiano, ed il leninismo nella forma del
populismo pauperistico. Questo spiega perché vediamo oggi il populista
pauperistico Aldo Brandirali nellarea politica di Berlusconi, e loperaista
Adriano Sofri fra gli apologeti del sionismo, delle guerre americane e
dellimperialismo più totale. Non si è dunque trattato di un "tradimento".
Nessun moralismo serve a capire il fenomeno. Questa gente non ha mai avuto in
nessun momento il minimo rapporto con Marx o con Lenin, e si tratta allora di
avventure della dialettica del tutto specifiche.
In quarto luogo, se si
esamina lideologia della lotta armata in Italia (sia sul versante Brigate
Rosse che in quello Prima Linea) si vede che si tratta semplicemente delluso
delle armi da fuoco a partire dal precedente demenziale paradigma teorico e
politico delloperaismo e del populismo pauperistico. Marx e Lenin non
centrano niente. Marx è il teorico del lavoratore collettivo cooperativo
associato, e Lenin è il teorico delle larghe alleanze di classe.
Tutto questo
era del tutto estraneo agli allucinati pistoleros, che erano mossi da tre
presupposti del tutto onirici.
Primo, una concezione paranoica del capitalismo
mondiale come meccanismo unitario e pianificato, il cosiddetto SIM, lo Stato
Imperialista delle Multinazionali (e questa concezione unitaria e non
concorrenziale resta oggi nellidea di impero senza imperialismo di Toni
Negri). Il capitalismo diventa lorganizzazione Spectre di James Bond.
Secondo, una concezione che definirei di operaismo mistico, per cui la classe
operaia di fabbrica continua ad essere vista come il gigante buono da
svegliare con azioni esemplari, alla faccia delle leniniane alleanze di
classe.
Terzo, una concezione che definirei di antifascismo mitico, per cui ci
si sentiva eredi ed emuli di Pesce, il partigiano dei GAP, e di Kamo, il
rapinatore di banche armeno del tempo di Lenin, e si vedeva un fascista in
ogni poliziotto democristiano ed in ogni ingegnere FIAT (questo antifascismo
mitico permane ancora oggi in chi continua a vedere Bossi, Berlusconi e Fini
dei semplici eredi del fascismo metafisico).
Come si vede questi tre
presupposti non hanno nulla a che vedere con il marxismo e con il leninismo.
Chi li ignora può ripetere questo luogo comune infondato, ma chi sa chi sono
stati e che cosa hanno scritto Marx e Lenin (ed io lo so) non si farà prendere
per il naso.
In quinto luogo, devo dire che lavvento del gorbaciovismo nel
1985 mi fece cadere in una comprensibile schizofrenia, che peraltro condivisi
con molti intellettuali marxisti del mondo. Da un lato, sulla scorta di
analisti marxisti come Paul Sweezy e Charles Bettelheim, ero convinto da tempo
che il socialismo reale fosse diretto da una nuova ed inedita classe
sfruttatrice, formatasi con il consolidamento delle burocrazie dispotiche
della fusione tra partito e stato (più esattamente, fra partito comunista e
stato socialista), e perciò nessuna riforma potesse partire dallalto in una
direzione di emancipazione socialista.
Dallaltro, continuavo pascalianamente
a sperare nellautoriforma della burocrazia, e che il baraccone potesse essere
salvato allultimo momento, perché mi era già chiaro che il crollo geopolitico
del baraccone burocratico avrebbe comportato il sorgere da incubo di un impero
americano unilaterale.
Con questi sentimenti schizofrenici affrontai il
fenomeno Gorbaciov, e ci misi molto per capire ciò che avrebbe dovuto essere
marxianamente chiaro, e cioè che la classe sfruttatrice dei burocrati di
stato, resasi conto di non poter continuare con il vecchio meccanismo
statalista e pianificato di sfruttamento, si sarebbe infine riciclata come
nuova borghesia compradora e speculativa del più solido e collaudato
capitalismo occidentale. Il che ovviamente avvenne, insieme con laffermazione
dellodioso ed ipocrita unilateralismo geopolitico americano. Meno Pascal e
più Marx, meno scommessa e più analisi, eccetera, mi avrebbe forse fatto
capire meglio le cose. Ma come disse il saggio proverbio, meglio tardi che
mai.
Sul piano intellettuale, cominciai a capire che la dicotomia di sinistra e
destra era del tutto inservibile per mettere a fuoco i problemi di un
eventuale rinnovamento del marxismo nel triennio 1991-1993, quando per
leditore Vangelista di Milano scrissi una serie di libri, fra cui una
trilogia dedicata ai rapporti rispettivi del marxismo con il nichilismo,
luniversalismo e lindividualismo.
Mano a mano che approfondivo lanalisi, mi
rendevo conto che la dicotomia non era solo inservibile, ma addirittura
fuorviante, e dava luogo a ciò che nel Seicento Bacone chiamava "idola", cioè
pregiudizi devianti.
Per quanto riguarda il nichilismo moderno, la sinistra ne
era stata addirittura il luogo privilegiato con la sua evoluzione dal
precedente storicismo progressistico al disincanto post-moderno della fine
della storia.
Per quanto riguarda luniversalismo, la sinistra era stata
storicamente il vettore principale del suo scioglimento nei particolarismi non
universalistici della classe (operaia) e del partito (socialista e poi
comunista). Ma luniversalismo della classe e del partito era stato sempre e
solo astratto, aprioristico e formale, mentre nella realtà storica non aveva
mai funzionato come tale.
Per quanto riguarda lindividualismo, infine, la
sinistra non aveva ripreso la preziosa indicazione di Marx sulla libera
individualità sociale (che per Marx avrebbe dovuto essere la base
dellantropologia comunista, dopo la dipendenza personale precapitalistica e
lindipendenza personale borghese), ma era caduta in forme di identità e di
appartenenza di tipo organicistico e tribale (il cosiddetto "popolo di
sinistra").
Insomma, non posso farla lunga per ragioni di spazio. Basti
concludere che fu proprio il processo di ripensamento personale a farmi
prendere atto del fatto che finché ragionavo in termini di opposizione polare
fra sinistra e destra non ne sarei mai venuto fuori.
Sul piano teorico avevo già dunque rotto con la dicotomia fino dai primi
anni Novanta. Ma restava ancora un radicamento emotivo di appartenenza, duro a
morire come tutti i radicamenti identitari ad origine biografica. La rottura
emotiva per me risale al marzo 1999, quando i bombardieri americani e dei loro
servi europei della NATO (con la lodevole eccezione della Grecia, patria della
filosofia) cominciarono a cospargere di uranio radioattivo la Jugoslavia. Da
vecchio conoscitore dei Balcani, sapevo perfettamente che non cera in corso
nessun genocidio e neppure nessuna pulizia etnica (cioè espulsione etnica di
massa da un territorio), ma solo una repressione armata di un movimento armato
indipendentista (una situazione comune ad almeno cinquanta paesi al mondo).
Sapevo anche che il movimento armato indipendentista albanese UCK perseguiva
la pulizia etnica dei serbi, mentre Milosevic non perseguiva quella degli
albanesi. Sapevo anche che gli americani erano del tutto indifferenti ai
cosiddetti "motivi umanitari", e volevano invece un insediamento militare
geopolitico nei Balcani (lodierno Camp Bondsteel).
Sapevo anche che i
cosiddetti colloqui di Rambouillet erano stati una trappola pianificata dalla
Albright. Bene, tutto questa era largamente noto, ed invece vidi la sinistra
che appoggiava la guerra americana, Veltroni che sfilava in suo appoggio,
che inneggiava sulle colonne del giornale-partito "La Repubblica",
che prestava il suo nome alla cosiddetta Operazione Arcobaleno,
eccetera. In quel momento in me si ruppe qualcosa. Poi lessi che la rivista
"Diorama Letterario" di Tarchi si era invece impegnata contro la guerra con
contributi pacati ed equilibrati, ed allora decisi che il "tabù dellimpurità"
avrebbe dovuto essere rotto proprio per preservare la mia salute mentale e la
mia dignità personale di studioso. E lho fatto.
Gli articoli apparsi originariamente su questo sito possono essere riprodotti liberamente,
sia in formato elettronico che su carta, a condizione che
non si cambi nulla, che si specifichi la fonte - il sito web Kelebek http://www.kelebekler.com -
e che si pubblichi anche questa precisazione
Per gli articoli ripresi da altre fonti, si consultino i rispettivi siti o autori
|
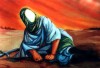
e-mail
Visitate anche il blog di Kelebek
Home | Il curatore del sito | Oriente, occidente, scontro di civiltà | Le "sette" e i think tank della destra in Italia |
La cacciata dei Rom o "zingari" dal Kosovo | Il Prodotto Oriana Fallaci | Antologia sui neoconservatori | Testi di Costanzo Preve | Motore di ricerca