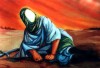Per agevolare la lettura, questo articolo di Costanzo Preve è stato diviso in sette parti, più un'introduzione.
All'introduzione
Alla parte precedente
Alla parte successiva
Dopo questi tre paragrafi dedicati ad una ricostruzione necessariamente
autobiografica, possiamo finalmente passare alla parte teorica. Inizierò
allora sostenendo che la dicotomia contemporanea fra sinistra e destra non
inizia a mio avviso nel 1789, come si tende a dire, ma si costituisce
veramente solo a partire dal 1871, ed ha una significativa accelerazione solo
dopo il caso Dreyfus in Francia, in cui si costituisce per la prima volta il
gruppo degli "intellettuali di sinistra" come gruppo identitario di
appartenenza stabile. Certo, questo riguarda solo l’Europa Occidentale, non
l’Inghilterra, l’America o la Russia, ma è egualmente interessante.
A proposito del periodo storico che va dal 1789 al 1871 so bene che molti
utilizzano ampiamente la dicotomia tra sinistra e destra per classificare le
posizione politiche contrapposte. Tutto questo è legittimo, ma non sono del
tutto d’accordo, perché c’è il pericolo di confondere queste categorie con il
loro uso attuale, che è diverso e talvolta opposto. Ad esempio la parola
"patria" nasce a sinistra, e ci mette quasi un secolo per transitare a destra
(e sta oggi tornando lentamente a sinistra, vedi il caso Chevènement in
Francia – proprio per la nuova situazione imperiale americana). Mazzini e
Garibaldi sono indubbiamente più a sinistra di Cavour, ma questo ci dice
veramente molto poco sul nostro risorgimento. Alcuni parlano di tre tipi
diversi di destra francese (la destra borbonica legittimista e
tradizionalista, la destra orleanista speculativa, liberale e faccendiera, ed
infine la destra bonapartista, populistica e plebiscitaria). Tutto vero, ma
anche tutto inutile per capire il presente. I nordisti erano chiaramente più a
sinistra dei sudisti, perché volevano liberare gli schiavi, ma erano poi i
portatori del capitalismo più selvaggio, oligarchico, banditesco e piratesco
della storia universale. Potrei continuare al lungo, ma questo mi basta per
chiarire come prima del 1871 preferirei non usare questa delicata dicotomia.
Fra il marzo e il maggio 1871 si sviluppò e fu sanguinosamente repressa la
Comune di Parigi. Un evento storico reale, ma anche un evento simbolico. Dal
punto di vista storico, la Comune chiude una fase, e non ne apre assolutamente
un’altra. Si tratta dell’ultima grande rivolta popolare ottocentesca, prima
della nascita del socialismo e del movimento operaio organizzato, partitico e
sindacale. Ma da un punto di vista simbolico, la Comune è l’occasione di uno
schieramento ideale. L’atteggiamento di Nietzsche verso la Comune di Parigi mi
sembra assolutamente sintomatico, ed è questa fra l’altro la ragione
principale per cui, a differenza dei post-moderni alla Gianni Vattimo,
considero Nietzsche un pensatore fondamentalmente di destra, e non un
pensatore dell’Oltreuomo posteriore alla dicotomia sinistra/destra. La Comune
di Parigi appare subito non solo come una comune insurrezione urbana popolare,
ma come il sintomo di una crisi di civiltà. Ed infatti è proprio così. Il
terreno filosofico della dicotomia fra sinistra e destra è proprio quello
dell’interpretazione corretta e della diagnosi della crisi di civiltà.
Ogni crisi di civiltà, o quella che si ritiene tale, viene giudicata in
base a parametri di classificazione teorica, che a sua volta traggono spesso
origine da reazioni emotive primarie. La distinzione fra destra e sinistra
richiede questi parametri di classificazione. Essi non sono sempre in qualche
misura arbitrari. Non esistono parametri storiografici definitivi. Ogni
generazione ne riscrive di nuovi. I parametri oggi più usati in Italia in
filosofia politica sono quelli proposti da Norberto Bobbio, ma questo avviene
proprio perché viviamo in un’epoca di egemonia liberale e neoliberale, ed i
parametri bobbiani sono particolarmente adatti a fondare questa egemonia,
perché sono stati programmaticamente costruiti sulla base della separazione
netta fra politica ed economia e fra forme e contenuti della decisione
politica.
I contenuti economici classisti della decisione politica sono per
Norberto Bobbio analoghi al noumeno di Kant. Essi sono pensabili, ma non
conoscibili. Sono una cosa in sé, non una cosa per noi. La uniche forme
modellizzabili sono le procedure formali della decisione politica, e questo
formalismo politologico è particolarmente affine alla riproduzione
capitalistica, che infatti tende a limitare il fattore politico a questo ruolo
subalterno e secondario. Occorre dunque prestare una certa attenzione ai
parametri di classificazione usati. E dico subito che vi sono due coppie di
parametri molto usati, che io però sconsiglio vivamente.
Una prima coppia di parametri da sconsigliare è quella fra conservazione e
progresso. In generale si classifica automaticamente la destra dalla parte
della conservazione e la sinistra dalla parte del progresso. Questo era
probabilmente vero alle origini del processo storico della modernità
illuministica, ma nel frattempo le cose si sono fortemente ingarbugliate. Non
vi sono dubbi sul fatto che il concetto di progresso è stato una creazione
dell’illuminismo (o meglio della sua corrente maggioritaria, perché c’è anche
un Rousseau che non vi credeva ed anzi lo avversava), è poi passato al
positivismo ottocentesco ed ha poi abbondantemente intriso l’ideologia prima
socialista e poi comunista.
E’ anche vero che il moderno conservatorismo ha
spesso come matrice storica la critica alla rivoluzione francese prima e dopo
il 1815, ma è anche vero che esiste anche una seconda matrice, la tradizione
liberale inglese antirivoluzionaria "whig" di Burke (destinata a rifiorire
nella critica anticomunista di Isaiah Berlin e di Hannah Arendt).
In
definitiva, mi sembra che il modello non tenga molto. Quando le anomalie e le
eccezioni cominciano a diventare troppo numerose, allora è bene che la
dicotomia venga prima criticata e poi decisamente abbandonata. A lungo la
sinistra ha accusato il capitalismo di conservatorismo, ed ha addirittura
etichettato come "conservatori" i suoi sostenitori. Questa etichetta è priva
di fondamento storico, e si applica soltanto (parzialmente) ai residui
nobiliari e alle classi legate alla rendita fondiaria ed in parte finanziaria.
Marx sapeva perfettamente che il capitalismo è la forza meno conservatrice che
esista, e che fa saltare in aria tutto ciò che sembra solido. Il gruppo
sociale più conservatore che esista in Occidente è forse la piccola borghesia
urbana di origine operaia ed impiegatizia. In compenso, il progresso è
divenuto nel Novecento una parola d’ordine legata all’innovazione tecnologica
connessa con il mercato capitalistico e con il suo allargamento, ed i suoi
maggiori critici provengono tutti da una matrice politica di sinistra. Ricordo
qui solo la rivendicazione della cosiddetta "antiquatezza" dell’uomo da parte
di Gunther Anders. L’ecologismo, e non solo il cosiddetto ecologismo
"fondamentalista", è oggi prevalentemente una forza di sinistra (o di
centro-sinistra), anche se molti suoi presupposti filosofici furono elaborati
nella prima metà del Novecento dalla cosiddetta "destra". In ogni caso,
dovunque ci voltiamo, appare del tutto chiaro che la dicotomia
conservazione/progresso non è più, ammesso che lo sia mai stata veramente, un
utile parametro di classificazione fra la sinistra e la destra.
Una seconda coppia di parametri, generalmente usata per classificare due
tipi diversi di sinistra (ma anche di destra), è quella che separa i
riformisti dai rivoluzionari. Nella polemica politica i riformisti vengono
talvolta chiamati moderati, ed i rivoluzionari estremisti. Si tratta di una
dicotomia pretestuosa e pigra, che in realtà non funziona assolutamente. E’
bene metterne in luce la matrice teorica, che è la concezione storicistica del
tempo. Se concepiamo infatti il tempo storico come un "medium" omogeneo ed
orientato, simile ad una strada lunga e diritta (e così lo concepivano le
ingenue ideologie del progresso), gli agenti storici possono essere pensati
come automobili che corrono più lente, e dunque più sicure, oppure più veloci,
e dunque più efficienti ma anche più insicure. I moderati riformisti sono
quelli che vanno piano, mentre i rivoluzionari estremisti sono quelli che
vanno forte, e dunque rischiano di andare fuori strada perché non rallentano
in curva.
Ma questa concezione della storia è assurda. Il tempo storico non è
per nulla una linea dritta con un prima e un dopo omogenei, e neppure una
strada a curve con gli stessi requisiti direzionali stabili. Il tempo storico
apre ogni tanto delle "finestre" di opportunità, che nessuno potrebbe mai
creare arbitrariamente con un puro atto di volontà, e queste sono appunto le
rivoluzioni che possono riuscire. In quanto alle cosiddette riforme, il guaio
è che molto spesso vengono battezzate "riforme" delle incredibili
controriforme peggiorative (riforma della scuola, riforma delle pensioni,
riforma della sanità, eccetera). Il termine riforma ha perduto oggi qualunque
significato connotativo, e viene usato esclusivamente in un contesto di
mistificazione ideologica.
Nello stesso modo il termine estremista è ormai
usato arbitrariamente per connotare qualunque comportamento ostile all’impero
americano ed ai suoi alleati, ed è diventato come il termine "terrorista". Bin
Laden lo è, mentre Bush guarda caso non lo è. Il massacratore Sharon non lo è,
mentre il povero Arafat lo è. I coloni razzisti israeliani non lo sono, mentre
gli eroici partigiani palestinesi lo sono. Non si tratta di semplice
confusione semantica, ma di vera e propria degradazione semantica. La
degradazione semantica è un segnale sicuro di corruzione sociale, ed allora
l’etimologia deve lasciare spazio alla politica rivoluzionaria.
Gli articoli apparsi originariamente su questo sito possono essere riprodotti liberamente,
sia in formato elettronico che su carta, a condizione che
non si cambi nulla, che si specifichi la fonte - il sito web Kelebek http://www.kelebekler.com -
e che si pubblichi anche questa precisazione
Per gli articoli ripresi da altre fonti, si consultino i rispettivi siti o autori
|
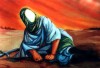
e-mail
Visitate anche il blog di Kelebek
Home | Il curatore del sito | Oriente, occidente, scontro di civiltà | Le "sette" e i think tank della destra in Italia |
La cacciata dei Rom o "zingari" dal Kosovo | Il Prodotto Oriana Fallaci | Antologia sui neoconservatori | Testi di Costanzo Preve | Motore di ricerca